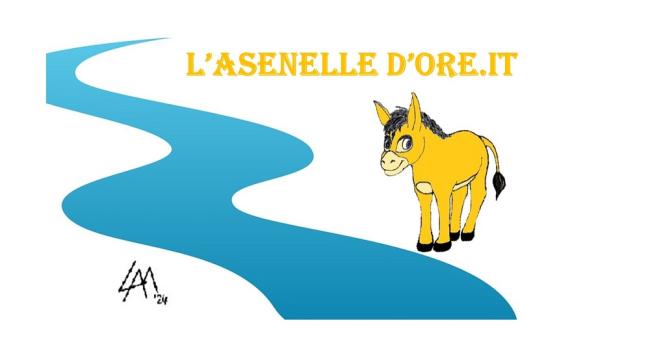Con questo racconto si chiude, dopo alcuni altri ancora inediti, anche la seconda serie dei “Racconti casalesi”. N.d.A.
Per chi non conoscesse Casalbordino e la sua topografia, era chiamata in dialetto dai nostri popolani (ma alla fin fine da tutti, perché diventato un toponimo) “firrijate”, “ferrata”, l’odierna via Nicola De Arcangelis, la scalinata panoramica che collegava la piazza principale, Umberto I, alla strada e ai parcheggi sottostanti (da quando la zona venne risanata abbattendo un pastificio dismesso negli anni ’60) ed era chiamata così perché i suoi gradini, oggi maiolicati nei montanti ed illustrati con i versi di una discutibilissima poesia in dialetto, erano affiancati da due corrimano in ferro (fino a quando non vennero sostituiti, probabilmente nel periodo fascista, da due scenografiche ringhiere in cemento) per aiutare il transito pedonale.
Bene, il nostro solito raccontatore di storie paesane un po’ misteriose, ci narra con molta dovizia di particolari (del resto questa è l’unica in cui fosse coinvolto direttamente) come, negli anni difficili del Dopoguerra e poi dei successivi anni Cinquanta, qui risiedesse ed operasse (proprio là dove, guarda un po’, passavano gli operai del pastificio, sempre a corto di soldi per la miseria dei salari, e le altre persone che salivano in piazza per affari) un omino dal naso aquilino, forse per la gobbetta dovuta al callo sul nasodei pesanti occhiali da miope, che lavorava in banca (non in quelle del nostro circondario, s’intende!) ed “arrotondava” lo stipendio, svolgendo l’attività collaterale di, come si direbbe oggi… consulente creditizio, ossia gestendo una finanziaria molto elastica, quasi “virtuale”, i cui capitali erano forniti da clienti danarosi, clienti della sua banca, ma non solo, probabilmente insoddisfatti del tasso d’interesse da essa praticato, che prestava soldi a coloro che ne avevano molto, molto, molto bisogno, talmente bisogno che non trovavano nessuno, nel sistema di credito ufficiale, in grado di soddisfarli, o perché ne avevano bisogno immediatamente, o perché non erano ritenuti pagatori affidabili, o per altri motivi, naturalmente ad interessi molto, molto, molto alti.
Insomma, il nostro tranquillo omino impiegato di banca era ciò che nell’ italiano scritto si chiama usuraio, in quello parlato “strozzino”, nel dialetto romanesco cravattaro (il senso di soffocamento è uguale in entrambi termini) e nel nostro, appunto, sanguòtte, ossia sanguisuga, che ti succhia il sangue, in senso figurato. E poiché si dice che dietro un grande uomo c’è una grande donna, probabilmente è vero anche il contrario, che cioè, dietro un pessimo uomo si nasconda una pessima donna, ed infatti l’omedeciòjeche a spingerlo verso quel “lavoretto” supplementare fosse stata appunto la moglie, donna evidentemente molto venale e scostante. Chiacchiere messe in giro da “clienti” pieni di rancore? Chissà!!!
Fatto sta che, tra di essi, in questo meccanismo stritolatore, che non guarda in faccia a nessuno, neanche ai morti, pur di riavere indietro i soldi prestati, più i corposi interessi e pure qualcosa in più, era rimasto impigliato anche il padre del nostro raccontatore, che, evidentemente per un bisogno impellente di liquidità, di denaro corrente, fatto normale negli anni del Dopoguerra, in cui il trasporto di denaro era assai difficile, come tutti i trasporti, divenne purtroppo debitore del nostro sanguotte, della somma in verità piuttosto alta per l’epoca, di cinquemila delle vecchie lire del Regno. Nel tempo pattuito il genitore onorò senz’altro l’esoso debito e per qualche anno ancora tutto sembrò essersi risolto per il meglio.
Quando però, nei pieni anni Cinquanta, il padre venne richiamato ai piani alti, o, come si suol dire più solitamente, passò a miglior vita, il nostro sanguotte ebbe la diabolica, malvagia, terribilmente banale idea, come solo il male può esserlo, da vero avvoltoio (altro che naso solo aquilino!!!) di presentarsi a casa del morto e di richiedere, corampopulo, di fronte a tutti gli intervenuti per la veglia funebre, ancora il pagamento delle famose cinquemila lire, forse contando o sperando che moglie e figli non sapessero del vecchio debito contratto dal defunto.
A questo punto il nostro collettore di storie ebbe, pur nel profondo dolore per la perdita del padre, la presenza di spirito, il sangue freddo, la dignitosa reazione di chi sa di essere nel giusto, di andare a prendere quella somma e di abbandonarla sprezzantemente,lasciandola cadere dall’alto, in modo che la banconota terminasse lentamente, per inerzia, la sua parabola discendente proprio ai piedi del nostro sanguotte, dicendo, sempre corampopulo, di fronte a tutti: «So che mio padre ha già onorato il suo debito, maio lo voglio onorare una seconda volta, rappresentandola come elemosina in suo suffragio!!!»
Dopo questa scena madre, che avrebbe dovuto far vergognare a molte il nostro strozzino, ciascuno tornò invece imperterrito al proprio mestiere, il nostro collettore al proprio rispettato ed onorato impiego pubblico e lusanguotte alla sua disonorevole ed amorale professione, che continuò ancora per qualche decennio.
Ma non finisce qui, perché, dopo che il nostro omino fu richiamato nell’altra vita alle proprie responsabilità di grave oppressore dei poveri, visto che la Procura celeste avocò a sé il caso montando il relativo procedimento, con un’altra ghiotta vicenda da seguire per i redattori del “Corriere della Nuova Gerusalemme”, “l’attività” venne continuata dalla vera ispiratrice della nostra storia, ossia la moglie, che per il gossip paesano era già venale e scostante, ossia attaccata al denaro e fondamentalmente allergica ad ogni relazione sociale, con il risultato che a lei cercava di rivolgersi solo chi proprio fosse all’ultima spiaggia e non sapesse che cos’altro fare.
Infine, a chiudere il cerchio di questa “singolare” e surreale dinastia, l’ultima esponente di essa ad occuparsi di tale miserevole mestiere fu la figlia, una donnina bassa e grassa, irsuta e un po’ baffuta, nonché con capelli corvini e sempre ingrassati,dalle mani tozze e gonfie (forse perché alla fine esse rifiutavano istintivamente ogni contatto con qualsiasi materia e, men che mai,con il cosiddetto “sterco del diavolo”, come era chiamato il denaro nel Medioevo), insomma dall’aspetto fisico e caratteriale piuttosto viscido, che non usciva mai di casa, ma che però, purtroppo, era molto visitata, pur non essendo certamente una di quelle di “via del Campo” (come le chiamava Fabrizio De Andrè), anche perché il fisico non glielo avrebbe permesso!!!
Eppure, non era neanche colpa sua, perché come può esserlo un bambino che cresce in un certo ambiente criminale o mafioso, che non conosce il lato benigno del sistema di valori, ma soltanto quello del male e dei relativi comportamenti? Infatti, alla fine era solo una vittima dei suoi genitori e della loro “attività”, perché quello non era esattamente un mestiere di cui andare orgogliosi e da raccontare agli altri per un bambino, e neanche, forse, era stata in grado di studiare per svolgere un qualsiasi altro lavoro.
Qual è allora il senso ultimo, la morale che si ricava da questa, tristissima e infamissima storia, come dalle altre raccontate? Che alla fine la verità, per quanto si tenti d’insabbiarla, o lo sia stata effettivamente, trova sempre la strada per ritornare a galla, come un fiume sotterraneo che torna sempre all’esterno, o una piantina che cerca tenacemente la luce del sole, e con essa tornano a brillare anche le figure di tutte le vittime dei malvagi, come quelle di tutti coloro che ebbero comportamenti esemplari, quale il nostro collettore di storie, che si ringrazia di vero cuore per gli spunti forniti e si saluta caramente … nell’alto dei cieli!